4. I Nuclei per la Difesa dello Stato
Dalla relazione della Commissione Parlamentare sul Terrorismo.
Documento aggiornato al 24/02/2006
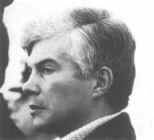 In sede giudiziaria (111) di recente e sulla base di riscontri istruttori di già apprezzabile consistenza è stato ipotizzato che gli intenti programmatici ampiamente enunciati nel convegno dell'istituto Pollio avrebbero avuto pratica attuazione nei due anni immediatamente successivi mediante la creazione di una vasta rete clandestina denominata "Nuclei di (o per la) difesa dello Stato", che avrebbe avuto notevolissima consistenza numerica e diffusione su vasta parte del territorio nazionale. La rete sarebbe stata operativa fin verso la fine del 1973, quando sarebbe stata sciolta per il timore che indagini giudiziarie su avvenimenti in cui la stessa era stata coinvolta, ne potessero consentire la individuazione. Sul piano di un primo riscontro oggettivo va sottolineato come la sigla "Nuclei di difesa dello Stato" compaia per la prima volta in una lettera che sul finire del 1966 fu inviata a molti ufficiali dell'esercito italiano per iniziativa - come ormai può ritenersi accertato - di due noti estremisti di destra quali Franco Freda e Giovanni Ventura. La missiva anonima conteneva un invito pressante e minaccioso ad aderire alla nuova struttura, che si affermava costituita "in seno alle forze armate" da "militari di grande prestigio e di autentica fedeltà" con "il compito di stroncare l'infezione prima che essa divenga mortale", partecipando ad una "lotta vittoriosa contro la sovversione". Nei suoi contenuti, quindi, sembrava muoversi nella logica ispiratrice di un noto pamphlet intitolato "Le mani rosse sulle forze armate" redatto da Pino Rauti e Guido Giannettini (112), che, come si è visto, furono tra i partecipanti di rilievo al con vegno dell'Istituto Pollio. L'inchiesta giudiziaria attualmente in corso ed alla quale si fa riferimento riprende e approfondisce spunti investigativi già presenti in vicende giudiziarie anteriori, in particolare nella nota indagine del G.I. di Padova, dottor Tamburrino, sulla "Rosa dei Venti". Di tali inchieste più antiche verrebbe ad essere confermata la principale intuizione: e cioè la non riducibilità di eventi che caratterizzarono drammaticamente la vita nazionale negli inizi degli anni settanta - e di cui in seguito ampiamente si dirà - ad una matrice esclusivamente "terroristico-insurrezionale", essendo possibile intravvedervi regie paraistituzionali e coinvolgimenti istituzionali. La nuova inchiesta si fonda su di una maggiore attitudine collaborativa di fonti già utilizzate nella indagine padovana, nonché su nuove emergenze istruttorie, le une e le altre idonee nel loro complesso a determinare una conferma delle già intuite responsabilità istituzionali, in particolare di un alto numero di ufficiali dei carabinieri e di settori del servizio di informazioni con funzioni di copertura. Il nuovo quadro indiziario è particolarmente arricchito:
In sede giudiziaria (111) di recente e sulla base di riscontri istruttori di già apprezzabile consistenza è stato ipotizzato che gli intenti programmatici ampiamente enunciati nel convegno dell'istituto Pollio avrebbero avuto pratica attuazione nei due anni immediatamente successivi mediante la creazione di una vasta rete clandestina denominata "Nuclei di (o per la) difesa dello Stato", che avrebbe avuto notevolissima consistenza numerica e diffusione su vasta parte del territorio nazionale. La rete sarebbe stata operativa fin verso la fine del 1973, quando sarebbe stata sciolta per il timore che indagini giudiziarie su avvenimenti in cui la stessa era stata coinvolta, ne potessero consentire la individuazione. Sul piano di un primo riscontro oggettivo va sottolineato come la sigla "Nuclei di difesa dello Stato" compaia per la prima volta in una lettera che sul finire del 1966 fu inviata a molti ufficiali dell'esercito italiano per iniziativa - come ormai può ritenersi accertato - di due noti estremisti di destra quali Franco Freda e Giovanni Ventura. La missiva anonima conteneva un invito pressante e minaccioso ad aderire alla nuova struttura, che si affermava costituita "in seno alle forze armate" da "militari di grande prestigio e di autentica fedeltà" con "il compito di stroncare l'infezione prima che essa divenga mortale", partecipando ad una "lotta vittoriosa contro la sovversione". Nei suoi contenuti, quindi, sembrava muoversi nella logica ispiratrice di un noto pamphlet intitolato "Le mani rosse sulle forze armate" redatto da Pino Rauti e Guido Giannettini (112), che, come si è visto, furono tra i partecipanti di rilievo al con vegno dell'Istituto Pollio. L'inchiesta giudiziaria attualmente in corso ed alla quale si fa riferimento riprende e approfondisce spunti investigativi già presenti in vicende giudiziarie anteriori, in particolare nella nota indagine del G.I. di Padova, dottor Tamburrino, sulla "Rosa dei Venti". Di tali inchieste più antiche verrebbe ad essere confermata la principale intuizione: e cioè la non riducibilità di eventi che caratterizzarono drammaticamente la vita nazionale negli inizi degli anni settanta - e di cui in seguito ampiamente si dirà - ad una matrice esclusivamente "terroristico-insurrezionale", essendo possibile intravvedervi regie paraistituzionali e coinvolgimenti istituzionali. La nuova inchiesta si fonda su di una maggiore attitudine collaborativa di fonti già utilizzate nella indagine padovana, nonché su nuove emergenze istruttorie, le une e le altre idonee nel loro complesso a determinare una conferma delle già intuite responsabilità istituzionali, in particolare di un alto numero di ufficiali dei carabinieri e di settori del servizio di informazioni con funzioni di copertura. Il nuovo quadro indiziario è particolarmente arricchito:A) dalla più ampia disponibilità offerta dal Colonnello Amos Spiazzi, che ha aperto uno squarcio sul "livello organizzativo e militare" del progetto;
B) dalle dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra relative al coinvolgimento di gruppi di destra e alla loro partecipazione organica nei Úquot;Nuclei di difesa dello StatoÚquot;;
C) dalla collaborazione di un ufficiale del Servizio Segreto, Capitano Labruna, già ampiamente noto alle cronache giudiziarie e alla pubblicistica che si è occupata del periodo;
D) dalle ammissioni di personaggi organicamente inseriti in gruppi di destra quali Ferro, Cavallaro e Stimaniglio. Secondo quanto prevalentemente emerge da tale quadro indiziario, (che peraltro, come meglio in seguito si dirà, non è completamente univoco) si tratterebbe di una struttura occulta nettamente distinta da Gladio e che solo in piccola parte in Gladio sarebbe confluita dopo il suo scioglimento. Diversa sarebbe anche la catena di comando e cioè il punto di riferimento istituzionale, individuato nello Stato maggiore della difesa. Secondo le nuove ammissioni di Spiazzi, invece, che appaiono comunque tese a minimizzare i fatti e il ruolo del dichiarante, si tratterebbe di una evoluzione e di uno sdoppiamento della struttura Gladio e quindi ancora di una organizzazione dipendente dal Servizio di sicurezza militare e volta principalmente ad assicurare la difesa del paese in caso di aggressioni esterne (113). Secondo altre fonti utilizzate nell'inchiesta, peraltro, non solo i Nuclei per la difesa dello Stato serebbero cosa diversa da Gladio, ma altre reti clandestine distinte dall'uno e dall'altra sarebbero state coevamente operative (così ad esempio il gruppo "Sigfried" di cui parlano, tra gli altri, Ferro e Digilio). Trattasi peraltro e complesisvamente di risultanze istruttorie che attendono ancora una verifica dibattimentale e che quindi meritano, da parte di questa Commissione, una valutazione ed una utilizzazione prudente. La stessa sarà operata, per rispettare l'ordine espositivo, quando si affronteranno i profili relativi alla ricostruzione di una serie di eventi che alla rete clandestina sarebbero riconducibili o nei quali la rete stessa avrebbe avuto un ruolo non marginale. E' altra tuttavia la conclusione che sin da ora appare possibile assumere: una pluralità di elementi convergenti convince che la realtà delle reti clandestine presenti nel paese nella seconda metà degli anni sessanta non è riconducibile, né strutturalmente, né funzionalmente, alla struttura Gladio per come resa nota alla Commissione ed al Paese dall'autorità di Governo. Chiaramente percepibile è infatti una realtà di dimensioni ben più ampie probabilmente polimorfa e riconducibile ad una pluralità di catene di comando di cui restano oscure le modalità di un collegamento, che pure in termini ragionevoli può ritenersi esistente. Si è già osservato affrontando il nodo Gladio, che nella prospettiva di indagine assunta dalla Commissione non appare poi decisivo affermare che la Gladio sia stata organizzata per "cerchi concentrici" o per "livelli distinti", ciascuno attivabile in ragione di un diverso obiettivo specifico; ovvero affermare che con Gladio convissero e da Gladio furono presupposte altre strutture paramilitari, che rispondevano a diverse catene di comando. La soluzione del problema può avere rilievo in una indagine giudiziaria volta ad individuare specifiche ed individuali responsabilità; vede invece scemare, anche se non sino all'annullamento, la sua importanza in un'indagine storico-politica, dove può essere sufficiente una ricostruzione anche per grandi linee di tale realtà occulta, per cogliere il senso di (e per esprimere una valutazione in ordine a) molti eventi che drammaticamente sconvolsero la vita del apese o tragicamente lo insanguinarono. Tutto ci&ogra ve; in una prospettiva di metodo che rifiuti l'azzardo di ipotesi e si ancori ad un ambito di certezze o almeno di elevate probabilità. In tali limiti è quindi già possibile riaffermare nel periodo storico considerato (e cioè nella prima metà degli anni sessanta) la realtà di strutture paramilitari che furono pensate per compiti che andavano ben al di là dello "stare dietro", nell'ipotesi sempre più improbabile di una occupazione bellica di parte del territorio nazionale, perché ebbero non solo compiti informativi, ma anche destinazione a fini di controinsorgenza e di contrasto politico, spinti in alcuni casi sino a progetti di natura golpista. Trattasi di una realtà che appare non riconducibile, nei suoi riferimenti istituzionali, soltanto agli apparati di sicurezza, bensì ad ambiti ben più ampi, anche in considerazione della circostanza che la stessa costituiva la traduzione in termini operativi di culture e interessi diffusi in strati ancora larghi del ceto dirigente italiano, anche se indubbiamente più ristretti di quanto fossero in un periodo anteriore. Anche in ragione di ciò può giustificarsi: - da un lato la maggiore "profondità" del livello sotterraneo in cui tale realtà venne in concreto ad articolarsi rispetto sia a strutture clandestine dell'immediato dopoguerra, sia al livello oggi conosciuto di Gladio, - dall'altro la non riducibilità al solo P.C.I. di un obiettivo di contrasto politico, che invece abbracciava tutte le componenti culturali e politiche e le singole personalità dei vari schieramenti, che operavano per una distensione internazionale, ovvero per instaurare democraticamente nel paesi nuovi e più avanzati equilibri politici. Anche ciò chiarisce un ulteriore aspetto che merita di essere sottolineato: la maggiore inerenza, rispetto a quella verificabile per il livello conosciuto di Gladio, di personaggi e gruppi della destra eversiva a tale più ampia realtà clandestina. Si è in presenza peraltro, ancora nel periodo considerato, come nel precedente quindicennio, di una sostanziale potenzialità operativa e cioè di strutture che non conobbero forme di attivazione fino a quando il quadro sociale e politico del paese non mutò profondamente per l'esplodere di un fenomeno opposto, (la contestazione studentesca e operaia), che caratterizzò il finire del decennio.


